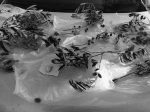Non saper far niente
Marcello Fagiani non è riducibile a uno.
Marcello Fagiani abitante del molteplice.
Da quindici anni agita e si fa agitare dal gruppo teatrale dei nontantoprecisi.
Marcello prende velocità nel mezzo.
Questo piccolo testo è un’eresia e di eresia abbiamo proprio bisogno.
testo di Marcello Fagiani
foto di Marta Reggio
Che questo blocco universale sembrava finto, all’inizio. Poi ben presto si è messa in moto la macchina della sospensione, una sorta di motore immobile che ha gettato tutta la popolazione in uno stato di straniamento generale: sospesi i gesti domestici, quelli consueti, sospesa l’economia e le relative relazioni sociali. Una forma di vita, il capitalismo dalla natura eterna, si fermava, improvvisamente. Per colpa di un virus. Grazie ad un virus. Ed improvvisamente la vita cambiò. Rimanemmo a casa, in questo pezzo di Umbria che si affaccia sulla sabina, in quest’ettaro di terra estranea. Ecco, la storia inutile di queste parole è la storia di come, per colpa o per merito di un virus, questa terra inizia a diventare amica. Almeno per me, alla terra in effetti non ho chiesto conto di questa nuova relazione.
Già da tempo, tra questo bosco di rovidi quest’ettaro di terra sconosciuta, avevo intravisto spuntare tra gramigna, olmetti e biancospini, degli ulivi che cercavano luce spingendosi in alto, unico spiraglio da dove poter prendere il necessario per affermare la propria vita. Un conato che mira all’alto.
Non so fare niente, ho qualche attrezzo, un decespugliatore, un tagliaerbe, una sega a motore che sfido, ogni volta che la uso, a lasciarmi attaccate alla mano tutte le dita. Non so fare niente. E me ne vanto. Nella precedente vita, quella da operaio, ho imparato che meno si sa fare e meno si fa. Sabotare era l’unica specializzazione che fosse necessario acquisire. In quello scontro, tra sabotatori e strenui difensori dell’etica del lavoro, era iscritto quasi per intero il conflitto tra Pci e movimento. La chiave a stella di Primo Levi, testo per altro molto bello, fu il manifesto di quel Novecento lavorista che vedeva nel progresso capitalista, quantunque riformato, la possibilità di emancipazione e di riscatto della classe operaia. Per noi, per la nostra parte di agitati e orgogliosamente rifiutati da e al lavoro, non saper far nulla, dentro la macchina di produzione capitalista, significava essere il granellino di sabbia che avrebbe dovuto bloccare l’ingranaggio. Essere un granellino, non mettere un granellino. Che poi le cose non siano andate proprio così è un fatto del tutto irrilevante. Almeno per ciò che concerne il racconto di questa storia. O forse no. È proprio a causa di quella sconfitta che, trent’anni dopo, mi trovo in mezzo ai rovi d’Umbria. Comunque sia, il fatto è che ora, sollecitato da Mattia, mi trovo a raccontare quest’insignificante vicenda.
Una vicenda, sia chiaro, che poco aveva a che fare con il luddismo; più affine, caso mai, all’ I don’t care dei Ramones. Insomma, per farla più dotta, al Pci dei giuslavoristi, del riformismo, del compromesso storico e di Primo Levi, opponevamo Balestrini di Vogliamo tutto e gli stalin. Che non avevano a che fare, quest’ultimi, con la famiglia del noto dittatore sovietico né con i suoi teorici. Erano invece, gli stalin, dei manici di piccone ai quali attaccavamo delle timide bandiere rosse con i quali andavamo in piazza, nelle manifestazioni, a dialettizzare con il Pci e la Cgil.
Non so far niente,
non sapevamo far niente
E una vanga o un piccone lo so tenere in mano solo al modo di come brandivamo quegli stalin. Insomma il lockdown, l’economia che si ferma come mai nessuno di noi avrebbe immaginato, il bosco di rovi e di olmetti che coprono gli ulivi.
E io dentro il bosco di rovi continuamente trafitto di spine che, con una sega a mano e un rastrello, mi faccio largo per arrivare al primo ulivo. Per avvicinarmi a lui, a loro, per liberarli di luce.
Dentro i rovi. Ma dentro i rovi inizia ad essere una locuzione che non mi soddisfa più. Forse dovrei scrivere tra i rovi, o con i rovi. Oh rovo!

La produzione capitalista si ferma a causa della sua (necessaria?) volontà di produzione e autoriproduzione e ci costringe a stare fermi. E pensare. E guardare. Respirare. Noi. Io e te. Da quanto non lo facevamo più, l’abbiamo mai fatto, di respirare sapendo di respirare, di camminare sentendo tutti i muscoli che si muovono? Di ascoltare i suoni che emergono dallo sfilarsi del rumore di fondo? Non è un fatto che riguarda il politico questa riflessione su quello che facciamo, sulla nostra vita? Ha scritto lucidamente Rocco Ronchi: «Con la forza oggettiva del trauma, il virus mostra che il tutto è sempre implicato nella parte, che tutto è in qualche modo in tutto e che non ci sono nell’impero della natura regioni autonome che facciano eccezione. Non ci sono nella natura imperi negli imperi come li chiamava Spinoza per irridere la pretesa superiorità dello spirito sulla “materia”. Il monismo del virus è selvaggio e la sua immanenza crudele. Se la “cultura” desolidarizza, se erige steccati e costruisce generi, se definisce gradazioni nella partecipazione al titolo di essere umano e istituisce orrendi confini tra “noi” e i “barbari”, il virus “accomuna” e costringe a pensare a soluzioni “comuni”. Nessuno nel tempo del virus può più pensare di salvarsi da solo né può pensare di farlo senza coinvolgere in questo processo la natura. Si dirà che la pandemia genera zone rosse, clausure domestiche, militarizzazioni del territorio. E questo è indubbio. Ma qui il muro assume un senso completamente diverso dal muro che il ricco costruisce per tenere lontano il povero.»
Certo, il virus, i morti, la tragedia. Il trauma
Certo, il virus, i morti, la tragedia. Prima del virus. Il virus del capitalismo, del razzismo, dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo e dell’uomo sulla donna. E quindi il virus ricaccia anche me in un certo comune, in una situazione nella quale sono invitato a fare i conti con quello che c’è, con quello che è accaduto e con quello che mi accade.

Il fatto è che questa mia vicenda personale ho il sospetto abbia a che fare con il politico e che quindi il personale poi, in fin dei conti, si dilegui in quella faccenda per la quale «tutto è in qualche modo in tutto». Dal mio punto di vista qui non si tratta di fare l’elogio del ritorno alla natura e di come siamo felici quando sentiamo il cinguettare del cardellino. No, non mi sembra questo il punto. Il fatto è che questo blocco, questa improvvisa fermata generale ci ha costretti e costrette ad ascoltare, a far caso ad ogni nostro istante, apparentemente inutile, sicuramente improduttivo, all’articolarsi delle relazioni, dei nostri respiri, delle nostre articolazioni, dei muscoli, della luce, delle cose. Questa frenata della folle corsa a produrre e a consumare ci ha gettato nella condizione di far caso a ciò che altrimenti avevamo dato per scontato, ovvio, e perciò distante e dimenticato. Ora sono qui tra i rovi e mi domando, intravvedendo le chiome di quell’olivo sempre più vicino a me: «che ci faccio qui, qual è la relazione che qui e ora metto in campo?». La gramigna, l’edera, gli olmetti, mi costringono a mettermi in campo. Ecco, campo mi pare essere un’altra parola chiave, una parola che può assumere diversi significati, anzi, direi, diversi appoggi. In quest’ettaro di terra, in questo campo abitato da specie vegetali, a me per lo più sconosciute, mi pare di vedere l’intero dispiegarsi di quel tutto in qualche modo raccolto in tutto. Non manca niente, in questo campo, non manca la vita che si esercita, che lavora con le sue tecniche, non manca tutto ciò che necessita. E non manca neanche l’azione, la potenza che muove ciò che non può che muoversi di vita e alla vita. E anche io, che piano piano imparo a smettere di guardare questo bosco di rovi e provo ad imparare a farmi bosco nel bosco, abbandono l’abitudine a guardarlo, questo campo, e provo a starci. Dentro il campo.
Ve l’ho già detto, non so fare niente
E tanto meno dipingere. Ma se fossi un pittore e quindi se fossi Cézanne, proverei a dipingere questo bosco Sainte Victoire includendomi nella visione. Dipingere lo sguardo, più che l’oggetto che si guarda, provare a dipingere l’atto della visione trovandosi magicamente anche dalla parte di ciò che si vede. Come cosa tra le cose, come gramigna tra la gramigna. Ecco, questo virus e questi miei ulivi, miraggi che diventano cose da toccare, mi fanno fare l’esperienza di un pittore che prova ad entrare nel suo quadro; questo campo mi chiama a farne parte, mi induce a cercarmi una posizione, a toccare, a stare seduto, tra la gramigna, accanto all’olivo oramai vicino a me. Stare a guardarsi come una cosa tra le cose, guardare la propria ombra che si confonde con l’ombra delle altre innumerevoli cose. Io vorrei essere amico, compagno di ogni pezzettino di vita che ho incontrato e che incontro in questo mezz’ettaro d’Umbria. Io vorrei essere amico e compagno di ogni pezzettino di vita. E certe volte mi sembra di poterlo essere, quando mi sembra di poter stare nel quadro, anch’io mentre dipingo. Perché ci credo davvero che «tutto è in qualche modo in tutto».
È finita che abbiamo raccolto le olive, anche quelle degli olivi “liberati” dai rovi seguendo, almeno in parte, il “disciplinare Veronelli” come indicatoci da Corrado e adesso abbiamo l’olio per tutto l’anno. Olio buonissimo, al modo di Cézanne!
Un olio per tutti e per nessuno!
Buon appetito.
da L’Almanacco de La Terra Trema. Vini, cibi, cultura materiale n. 19
16 pagine | 24x34cm | Carta cyclus offset riciclata gr 100 | 2 colori
Last modified: 9 Ott 2024