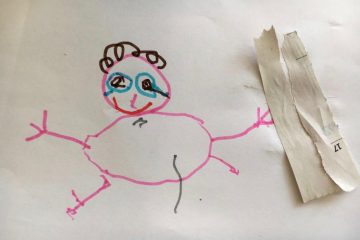di La Panchovilla*
disegni di Mattia Pellegrini
Alcune considerazioni per riportare in questo interessante dibattito sulle pagine de L’Almanacco la nostra critica alla metropoli e al suo ruolo strategico nel processo di valorizzazione del Capitale, dopo il pandelirio.
Nel luogo di espressione architettonica dei poteri e della diffusione dell’ideologia delle classi dominanti c’è ancora spazio per le città insubordinate, dove sia il corpo sociale a determinare quanto possano o non possano muoversi le élites?
In questi ultimi mesi ci siamo incontrati in differenti gruppi e abbiamo discusso di temi e in modalità che non trovano molto spazio nei circuiti che abbiamo frequentato e vissuto per tanti anni. I contenuti emersi nelle discussioni ci hanno arricchito e forniti di tanto materiale prezioso di approfondimento, relazioni ricche e intense che possono riaprire a un dibattito generale sulle forme di vita nell’epoca della sostituzione e dell’estinzione
Dal momento che non esiste più un fuori dal Capitale, considerato che tendenzialmente il 70% degli umani vive assiepato nelle metropoli e che non ci resta più quasi nulla di selvatico perché abbiamo distrutto già tutto, i termini Capitale/Metropoli/Mondo potremmo ormai considerarli sinonimi.
È opinabile che dopo il processo di gentrificazione/turistificazione/smartizzazione, ci sia ancora nella metropoli un corpo sociale. Procedure che mirano ad individuare e digitalizzare le relazioni si affermano anche nelle città del Mediterraneo dove la ri-dislocazione della rendita immobiliare impone una massiccia fuoriuscita dei non abbienti verso il periurbano, disgrega e mercifica la vita di quartiere, abolisce di fatto l’economia di vicolo.
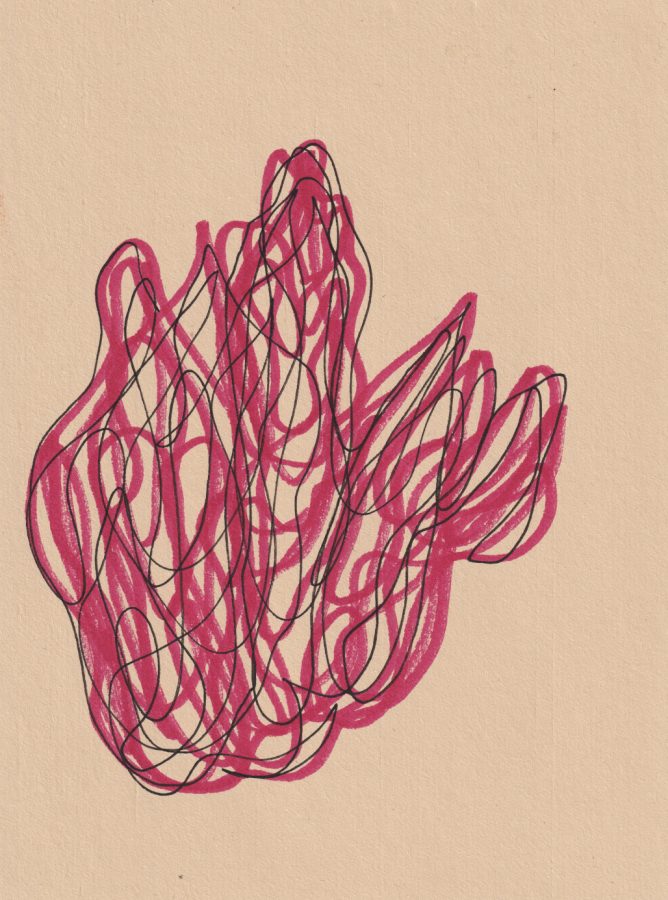
La chiamano antropocene o capitalocene, c’è chi dice Chthulucene. Fatica Jason Moore a dimostrare che è tutta responsabilità del sistema capitalista. Non che sia fuori strada, però che il capitalismo sia cattivo lo sanno anche i bambini, bisognerà capire perché noi occidentalizzati scegliamo sempre quello. Per molte centinaia di milioni di persone, soprattutto da questa parte del mondo, si tratta dell’unico supporto vitale.
Senza supermercato non si mangia. Senza carburanti fossili non ci si muove, senza Acea non si beve, non ci si lava.
I compromessi, ai quali ogni giorno ci abbassiamo per sopravvivere, sono la soglia di cui prendere sinceramente atto, senza infingimenti, la soglia tra l’adesso e il mondo che auspichiamo.
Si parte da questa soglia. Consapevoli che nella metropoli, l’ultimo sapiens assume l’opportunismo come codice di comportamento, gli individui sono pronti al tradimento, l’amante del giorno prima è l’assassino del giorno dopo.
L’Etica in quanto filosofia della prassi si è esaurita. Consumo dunque sono.
C’è ancora la possibilità di esistenza di comunità metropolitane autonome, anche qui, in qualche nicchia dell’occidente? Ci sarà la possibilità di un movimento che sollevi il pavé e vi trovi sotto la spiaggia?
Sembrerebbe di no. Restiamo comunque aperti ad ogni imprevisto mentre ci attrezziamo per non soccombere.
Abbandonare la metropoli può incarnare l’abbandono di questo mondo. Ma la campagna italiana, non è parte separata dalla metropoli. È infatti funzionale a questa. Di giorno le migliaia di automobili nei parcheggi delle stazioni dei paesi, il vuoto che lasciano la notte, ci dicono quanta forza lavoro segua i flussi del valore verso la città. Anche lo stile di vita dei cittadini neo-rurali è in larga misura lo stesso di quello urbano. Gli aperitivi al baretto del paesino gentrificato, laddove persiste un vivere. Nel borgo in via di abbandono invece, silenzi nei vicoli e nelle piazzette che accoglievano la socialità medievale, giardini di scuolette pubbliche abbandonate ormai da un paio di generazioni, habitat favorito di rovi e di una microfauna di confine tra terra e cemento. Fontanili seicenteschi in rovina nei crocicchi di valli un tempo produttive, ormai terre marginali, ricordano gli usi civici non più attivi dai tempi delle bisnonne. Forni di paese senza comunità che li accendevano per panificare, tratturi senza greggi, fossi abbandonati e senza manutenzione dove le acque si interrano e ristagnano. L’arrivo di folle di consumatori non porterà che nuove disgrazie. L’ecosistema montano è assai fragile. Non è con questi presupposti che lo si può abitare.

In questo mondo che brucia, il valore si autonomizza perfino dal processo storico capitalistico presentandosi come forma senza contenuto. Il capitale non ha più bisogno neanche della sua comunità. Incrementare il denaro attraverso il denaro è l’unico scopo rimasto dopo le fasi mercantile e industriale. La rivoluzione informatica applicata alla finanziarizzazione ha fatto il resto. L’aumento della densità demografica ha come corollario il processo di espansione e capillarizzazione dei dispositivi di disciplinamento e controllo. Separare la circolazione buona da quella cattiva per garantire flussi senza interruzione nella catena della distribuzione, come sempre, ma in più con la cybernetica. La logistica di guerra applicata alle infrastrutture civili, attraverso le conferenze dei servizi e la bastonatura poliziesca degli scioperi del comparto, è il motore della nuova colonizzazione dei territori, della ri-dislocazione dei poteri, di una modifica sostanziale dell’orografia e della vocazione dei luoghi, di una ulteriore soggettivazione di massa. E se lor signori sapranno sfruttare appieno le risorse e i poteri derivanti dal PNRR l’ennesima catastrofe è garantita.
Il tema dei beni comuni rimane certamente suggestivo per la sinistra istituzionale.
La nascita del concetto di bene comune avviene intorno al XIII secolo.
È ideologia dell’aristocrazia urbana dei comuni medievali che fregia le facciate dei propri palazzi con dipinti o arazzi, stucchi e altre tecniche con soggetti che fanno riferimento alle opere finanziate per la città. Per il proprio prestigio familiare e per la gloria personale. Tra queste opere troviamo spesso, in ambito militare la manutenzione o la costruzione di mura cittadine e delle torri, oppure di forniture militari o atti di eroismo a favore della città. In ambito civile il mecenatismo verso le arti e le opere infrastrutturali tipo palazzi, piazze, monumenti, finanziamento dei sistemi viari, delle dighe o dei porti cittadini. In tempi recenti dalle sinistre come rafforzativo del concetto di bene pubblico.
Sul piano politico è un concetto “senza prassi” nel senso che chi lo afferma, rivendica che sia lo Stato a gestire. Non parliamo di uso collettivo, dunque, non entriamo nei concetti di valore d’uso, di autogestione dei mezzi di produzione e di riproduzione sociale.
In seconda istanza, per riprova della sua debolezza concettuale, c’è da osservare quanto avvenuto durante e dopo il movimento referendario sull’acqua pubblica. Il concetto è stato sussunto dalla politica istituzionale attraverso il Pd, in particolare da Bersani e i suoi accoliti, affossando in parlamento la vittoria referendaria, lasciando praticamente intatto il monopolio della gestione privatistica delle acque pubbliche.
È una parola “baule” che non genera conflitto, sedizione, secessione, abbandono, non costruisce un no, non definisce un fuori. È un concetto che spinge alla partecipazione e al coinvolgimento nelle dinamiche istituzionali, in sostanza alla collaborazione con le classi dirigenti.
Il fraintendimento credo derivi dal termine inglese “Commons” il quale però non era un concetto astratto ma estremamente pratico di utilizzo delle terre, degli usi civici, per l’approvvigionamento dei villaggi, prima della rivoluzione industriale innescata dal rapido e profondo processo di espropriazione e chiusura dei campi e la migrazione di migliaia di abitanti rurali, rovinati, verso le fabbriche delle città che li hanno schiavizzati, ammalati, abbrutiti.
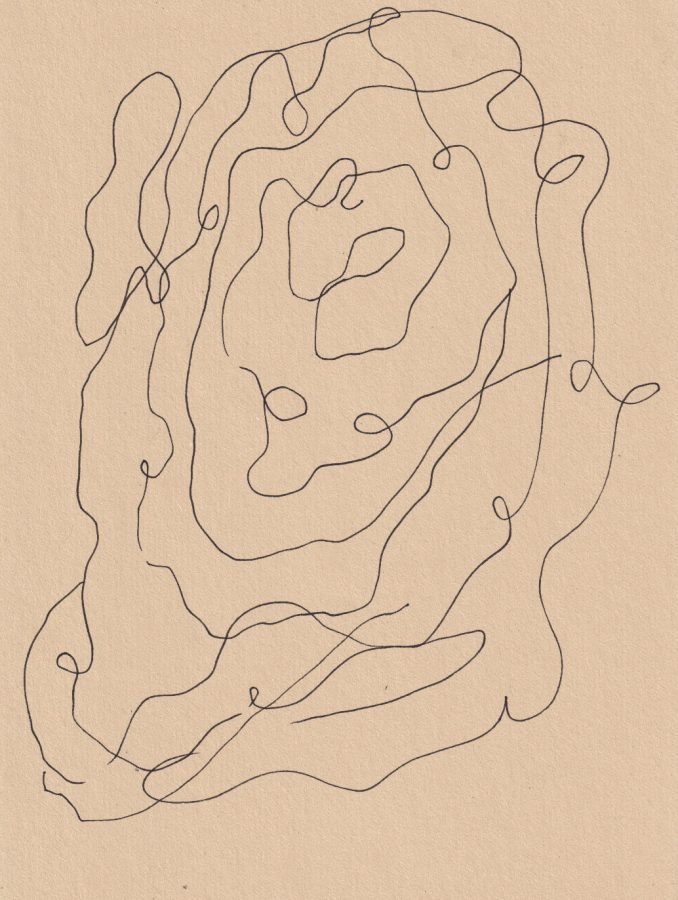
In un certo senso, il concetto di valore d’uso è legato indissolubilmente al modo in cui abitiamo il mondo. La linea di condotta della specie umana è stata quella dell’abuso, di sé e degli altri. Le politiche estrattiviste ne certificano la precipitazione finale. Ad ogni buon conto, nella storia umana sembra non esserci mai stata un’età dell’oro. Se non, forse, ai tempi della foresta quando l’homo era ancora un’ospite sulla Terra.
La domanda è: come re-imparare a vivere con il mondo, comprendendo – abbracciando – l’interezza del vivente, quando ogni comunità diviene evanescente?
Senza astrarre, quella terra con la t minuscola, quella vera che odora, che possiamo toccare, in cui possiamo fare le capriole, in cui facciamo crescere talee di officinali e piantine da coltivare dai semi dei peperoncini di Casa Galeone.
Abbiamo bisogno di fare esperienza mettendo le mani nella terra, di capire cosa si prova a piantar alberi in autunno, al cospetto della danza delle lucciole nelle sere di maggio dopo il tramonto, allo sbocciare delle stelle di Betlemme, a far crescere i pomodori o l’orzo, a dividersi il frutto della produzione collettiva, a leggere insieme Baudelaire nell’uliveto.
Rigenerare noi stessi nella natura, essere la rivoluzione di un filo di paglia.
È la pienezza della vita, unico senso del vivere che ci ricostituisce in forze. Alimenta la gioia e l’anelito alla liberazione nel nostro passaggio fino al momento della nostra ricomposizione con la terra. Una vita non può essere vissuta facendo politica, la militanza acceca per lo più. La vita senza bellezza è solo un grigio trascorrere degli anni a nostra disposizione. Un rivoluzionario, una rivoluzionaria che perde la poesia diventa un burocrate. Resistere è ancora situarsi nell’attesa. Invece sta succedendo tutto ora. Stiamo facendo un salto antropologico. Adesso è il momento per tentare di volare.
Un giardino si annuncia al suono della siringa di Pan e della lira di Hermès. Una donna, Diotima, ci accoglie e ci guida tra popoli rudi, ingentiliti dalla poesia e dalla danza. I campi, terre dure da lavorare in comune, punteggiati di colori vivaci di fioriture, verdi o dorati all’alternarsi delle stagioni, sotto cieli attraversati da stormi di uccelli in migrazione, danno frutti che si condividono. Gli utensili necessari alla vita quotidiana possono essere costruiti e riparati da chiunque facilmente, le relazioni sono sincere. Chiunque riceve e fa ad altri dono di sé, ogni incontro è occasione di festa e di benevolenza. Non esiste proprietà privata, i mezzi di produzione sono autogestiti. Non ci si fa sottomettere, non si obbliga altri a sottomettersi. Gli umani sono in armonico equilibrio tra loro e con la natura.
Se il deserto che attraversiamo, dopo aver tutto distrutto, è senza confini, allora dovremmo tentare di essere noi stessi quel giardino.
La Panchovilla* si trova nel territorio della Sabina.
Dopo otto anni di esperienze tra città e campagna è oggi un luogo di incontro per attività editoriali, corsi di autoformazione, autoproduzioni birrarie e agricoltura naturale.
Il tentativo è quello di abitare il mondo radicandosi in un luogo, prendendosene cura, cambiando sguardo, imparando i tempi della terra e la sua radicalità.
Destituire la metropoli, abbandonare la sua forma di vita e la sua logica estrattivista che vede la campagna come museo o come risorsa.
La Panchovilla è uno spazio di diserzione dove si tenta di sperimentare la vita.
Da L’Almanacco de La Terra Trema. Vini, cibi, cultura materiale n. 29
16 pagine | 24x34cm | Carta cyclus offset riciclata gr 100 | 2 colori
Per ricevere e sostenere questa pubblicazione: info@laterratrema.org
Last modified: 28 Ago 2023