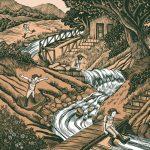CONSEGNARE UNA CASA ALLE GENERAZIONI FUTURE
Il passaggio generazionale a Valli Unite
di Leonardo Lovati
foto di Paolo de Giuli
È ormai da qualche mese che lavoro come vignaiolo a Valli Unite. Mi sono avvicinato il 25 aprile scorso, quando sono stato invitato a parlare di crisi climatica e modi possibili di mobilitazione per resisterle, partendo dalla mia esperienza diretta nel movimento Ultima Generazione. Poi ho fatto qui una vendemmia e quest’anno ho deciso di passare la stagione. Non serve fare troppe presentazioni della Cooperativa Valli Unite perché è già rinomata nell’ambiente del biologico e del vino, ma qualcosa bisogna pur dire. Fondata nel 1981 da Ottavio Rube, Enrico Boveri e Cesare Berrutti, aveva lo scopo di mantenere e ampliare le conoscenze contadine, tramandarle alle generazioni future, e creare uno spazio accogliente, dove la possibilità di creare una comunità e di vivere dignitosamente si incontravano. Si posiziona sulle colline tortonesi, a un quarto d’ora di macchina da Tortona, in un paesaggio rurale costellato da vigneti di barbera, croatina e timorasso, con diversi ettari di bosco a fare da contorno. Il paese si chiama Costa Vescovato, in provincia di Alessandria. L’idea che ha dato vita al progetto, sulla scia delle esperienze comunitarie del ‘68, era quella di mettere in condivisione con il paese una stalla per sottrarsi dalla produzione di massa dei fertilizzanti. Questa idea iniziale non aveva trovato spazio ma i tre fondatori si sono reinventati e hanno messo in comune tra loro i campi e le vigne che possedevano. Come scriveva Jean Giono nella sua Lettera ai contadini sulla povertà e la pace, la vita del contadino e il suo lavoro coincidono, non si possono separare. Fare il contadino è uno stile di vita totalizzante, pacifico, che ti inserisce di per sé all’interno di una comunità che si aiuta a vicenda. E, sempre come scrive Giono, è stato il denaro e la messa in produzione dei campi a dividere la ricchezza dai contadini, dal loro lavoro che dà abbondanza. Così Valli Unite ha cercato, per quanto possibile, di ritrovare quello spirito che Ottavio, uno dei fondatori, chiama contadinità. Da qui la scelta di costruire una cooperativa dove sono i soci, che negli anni entrano, a guidarne la tendenza, e non una persona o un gruppo dall’alto. La storia di Valli Unite è stata raccontata due volte attraverso le interviste ai fondatori e alle altre persone che vivono qui, nei libri di Manlio Calegari, La porta aperta e Il valore aggiunto, scritti a circa dieci anni di distanza l’uno dall’altro. Nel caso in cui si fosse interessati a seguire il processo di costituzione, dalla proposta di condividere la stalla tra gli abitanti di Costa Vescovato al come si è evoluta la cooperativa venticinque anni dopo rimando a quelle pubblicazioni.
Dopo poco più di quarant’anni la cooperativa conta circa venti persone socie e una quindicina di dipendenti. In Italia è un’autorità nell’agricoltura biologica e nella produzione di vino naturale, conosciuta per il suo impegno nel riportare un esempio di comunità agricola e per le sue iniziative sociali. Attorno a Valli Unite negli anni si sono costituiti altri progetti grazie al passaggio in questa realtà, come le anime dell’azienda agricola Umaia1 o il campeggio sociale La Campeggia, rendendo i colli tortonesi un luogo vivo e pieno di energie, aperto all’esterno e ricettivo ai cambiamenti.
Parlando di questo articolo con le persone del luogo spesso è emersa una delle questioni cruciali che riguarda il mondo contadino: che ne sarà di Valli Unite quando responsabili e soci di questo posto non potranno più lavorarci? Come tenere in piedi una macchina che produce una trentina di stipendi con il passaggio generazionale?
Nicole, presidentessa della cooperativa da otto anni, afferma che questo punto è uno dei nodi centrali delle loro riflessioni, data la fatica nel trovare persone che si inseriscano stabilmente da un lato, e il rischio che questo sia un investimento infruttuoso dall’altro. Le stesse persone che sono nate qui faticano a rimanere, vogliono cogliere occasioni attorno al mondo e uscire dall’ambiente inevitabilmente chiuso del lavoro in campagna.
Forse c’è consapevolezza della “morte” del lavoro contadino e si fatica ad affrontarla, anche perché non è voluta. D’altra parte, vivere la terra significa anche resistere per essa. Molte forme di resistenza all’espropriazione vanno di pari passo con un ripensamento del lavoro agricolo. Si vuole quindi resistere alla dissoluzione delle comunità imposta dall’agricoltura industriale. Come riuscirci è il grande mistero. Ogni migrazione è una piccola morte di una parte di sé, ogni luogo da cui si parte è sacro nella misura in cui lo si ricorda come una casa. E il paesaggio dei colli tortonesi è particolarmente adatto per essere considerato ospitale, dolce e con l’aria tranquilla, una bella casa. Le persone vogliono restare, ma per farlo c’è bisogno di avviare questo cambio generazionale.
Il passaggio dei giovani dalla campagna alla città è stato forse il primo grande sradicamento che, dalla rivoluzione industriale e poi attraverso l’Unità d’Italia e il relativo colonialismo del Sud, ha separato le comunità agricole, costruendo una prima frattura ecologica attraverso, almeno per quanto riguarda l’Italia e l’Europa, la privatizzazione dei terreni e l’industrializzazione del lavoro agricolo. Venne a crearsi anche una frattura sociale. I contadini fino alla fine degli anni Settanta erano visti con disprezzo. Forse proprio nel momento in cui si criticavano maggiormente gli stili della vita consumista delle città, la figura del contadino è tornata a emanciparsi. Quarant’anni più tardi e dopo venti dall’ultimo tentativo di costruire un altro mondo possibile, il G8 di Genova. Questo cambiamento nelle idee di chi abitava le città ha permesso alla cooperativa di avere un ricambio costante di persone nuove.

Valli Unite è riuscita nel tempo a far fronte a diverse necessità: provvedere al reddito dei suoi dipendenti, lavorare come una vera cooperativa con le decisioni prese collettivamente e la partecipazione alle assemblee di tutte le persone presenti, produrre per un mercato competitivo come quello del vino e coprire i costi di macchinari e produzione. Non è sempre stato facile farlo e il “saper fare” si è costruito negli anni. Ora portare avanti questa costruzione non è banale. Il mercato, il mondo, stanno cambiando a una rapidità forse mai vista. Le colture sono a rischio non solo dalle crisi economiche ma anche dalla crisi climatica e dalle guerre. La possibilità di perdere molto da un anno con l’altro diventa sempre più evidente man mano che il tempo dentro alla biosfera procede. Per questo la domanda sul passaggio generazionale si fa sempre più rilevante. Non è solo una questione di trasmissione da una generazione all’altra dello stesso lavoro ma è la costituzione di un altro modello. Bisogna capire se questa trasformazione può essere incarnata dalle nuove generazioni, se si sta sviluppando una base per permettere questo passaggio. Ho allora intervistato alcune persone, giovani tra i venti e i trent’anni e chi invece è tra i fondatori di Valli Unite, per capire meglio come si sta configurando il futuro della cooperativa.
Le prime persone con cui ho parlato sono Ottavio, Alessandro e Franco. Ottavio è appunto uno dei fondatori. Alessandro è responsabile della produzione e delle vendite del vino. Franco è responsabile della vigna. Hanno visto già diversi cambiamenti e per loro Valli Unite ha bisogno di giovani che prendano in mano le attività già impostate della cooperativa e creino nuovi progetti.
Il lavoro qui ha un ruolo sociale, cerca di creare occupazione in maniera diffusa. Non si fa per i propri figli o, almeno, non per costruire un nido in cui è solo la propria famiglia a beneficiarne. Persone nuove sono necessarie perché accada un passaggio “ereditario” dell’attività.
I figli e le figlie di Valli Unite godono sicuramente di privilegi, potendo lavorare da subito nell’agriturismo, nei campi o in cantina, ma questo non dà altri poteri decisionali. Molti di loro, di fatto, hanno preso strade diverse. Racconta Alessandro di come adesso ci si trovi in una fase di attesa: si aspetta chi vuole prendere in mano i processi che si svilupperanno in futuro. I figli sono troppo giovani per immaginare l’orizzonte del ritorno, malgrado alcuni mettono in preventivo di farlo dopo le esperienze in giro per il mondo.
Le modalità produttive, inoltre, dovranno cambiare in risposta alle crisi ecologiche che avverranno.
Si tratta di avviare processi sostenibili economicamente ed ecologicamente ma, in questi anni, agricoltori e contadini si trovano tra la propensione economica all’accrescimento della produzione per mantenere prezzi adeguati e la necessità ecologica di diminuire le produzioni. I fondi della PAC favoriscono solo le grandi produzioni, mettendo realtà come Valli Unite, o quelle ancora più piccole, in estrema difficoltà: altro sradicamento. La volontà di fare un prodotto biologico o rispettoso dell’ambiente (sia naturale che sociale) è compromessa dal mercato, dalle politiche europee, dalle lobby dell’agroindustria. Bisognerà decidere assieme come porsi.
Le nuove tecnologie agricole, soprattutto per quanto riguarda i macchinari e gli OGM, sono la soluzione più rapida e sicura proposta dalle lobby, ma dietro queste si celano una centralizzazione del potere delle multinazionali e il ricatto dei fondi europei per accedervi; per non parlare della questione dei brevetti, uno dei nodi della questione TEA/NGT, i nuovi OGM.
Col dominio delle macchine e della digitalizzazione l’occupazione diminuisce, così come la comunità nel lavoro e la conoscenza delle pratiche. Allo stesso tempo meno persone impiegate potrebbero incidere sugli stipendi delle persone che lavorano. Questo è l’impasse che contrappone una logica di sopravvivenza aziendale a una logica di sopravvivenza della comunità, un nodo centrale anche per i contadini del passato che, in nome della sopravvivenza, hanno scatenato delle grandiose rivolte, come scrive lo storico James C. Scott in I contadini, tra sopravvivenza e rivolta. E, in parte, questo scontro tra tendenze si può già intravedere nelle manifestazioni dei trattori di fine 2023, dove quelle due anime si incontravano e scontravano per il timore di perdere la base del loro reddito. Siamo, anche qui, di fronte al nodo del passaggio generazionale: quali saranno i valori che animeranno le prossime generazioni nel lavoro agricolo? Quale modello si rivelerà più capace di far fronte alle crisi del futuro? Quali saranno i rapporti di forza che vinceranno?
Le altre persone con cui ho parlato si chiamano Serena, Camilla, Maura e Roberto. Maura e Camilla sono figlie di Valli, mentre Serena e Roberto lavorano qui da un po’ di tempo. Le figlie di Valli mi raccontano come è stato nascere qui, dove ogni persona viene pensata come un parente e la comunità è molto forte. I problemi per loro sono diversi. Camilla vorrebbe aprire di più le manifestazioni a un pubblico diverso, magari tortonese: ha molti amici là che però non si ritrovano nelle feste della cooperativa, magari per via dell’impronta ideologica o per la scelta musicale. Nota, inoltre, che la comunità si sia andata man mano affievolendo per diventare luogo di lavoro inteso come tale, anche se gestito come una cooperativa. Serena, ad esempio, preferisce un modello diverso, cercando un equilibrio tra gli spazi del lavoro e della vita privata. Per Maura, invece, il problema principale legato al passaggio generazionale è la difficoltà nell’integrazione di persone nuove. Nonostante ci sia la possibilità di diventare soci relativamente presto moltissime persone che possono essere considerate “di Valli” hanno deciso di non associarsi. Per Maura c’è anche una difficoltà nella formazione: ogni decisione, ogni responsabilità su chi gestisce il lavoro dei nuovi operai agricoli rimane sulle spalle di chi ha più esperienza o anzianità. Se, da una parte, così si evita di avviare progetti che non rendono o vengono abbandonati per via dell’inesperienza, dall’altra parte il rischio è quello di bloccare chi potrebbe dare di più. Per Maura il grado di apertura di Valli è molto alto e ha permesso a tante persone di proporre progetti e portarli avanti. Per Roberto, residente qui da sette anni, non c’è luogo come Valli Unite che risolva con la stessa rapidità le situazioni di urgenza. Durante il COVID ha vissuto l’assemblea come un momento decisivo per organizzarsi all’interno di una situazione che inevitabilmente ha portato conflitto all’interno delle comunità. Trattare quanto succedeva insieme ha permesso di passare attraverso quel momento e risollevarsi in maniera positiva. Quell’esperienza è una base su cui affrontare le prossime sfide.
Il passaggio da una generazione all’altra tocca diversi aspetti: valoriale, tecnologico, di impostazione del lavoro, personale ed economico. Valli Unite sta elaborando un lavoro in questo senso, ma non ha ancora trovato risposte definitive. È una riflessione che può essere estesa a ogni azienda agricola o cooperativa in cui la pianificazione è parte centrale del lavoro. Davanti a noi si prospettano tempi incredibilmente incerti, siamo negli interstizi e nei nodi del prossimo assetto storico. Personalmente spero che l’animo comunitario resista perché penso che sia proprio la rete di comunità a concretizzare la possibilità di una resistenza contro le oscillazioni di un mercato e di un mondo sul bordo del collasso.

1 Dell’esperienza di Umaia si è scritto in un articolo di Laura M. Alemagna In approccio alle ombre pubblicato sul n. 35 de L’Almanacco de La Terra Trema. Vini, cibi, cultura materiale
Da L’Almanacco de La Terra Trema. Vini, cibi, cultura materiale n. 38
16 pagine | 24x34cm | Carta cyclus offset riciclata gr 100
Per ricevere e sostenere questa pubblicazione: info@laterratrema.org
Last modified: 15 Dic 2025